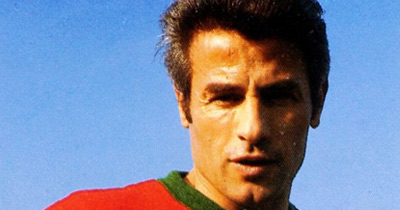PALERMO – L’ultima volta che l’ho visto, Corrado Viciani, fu al porto. Era una tarda serata dell’estate del ‘75 e reggeva con fatica due grosse valigie: stava lasciando Palermo (e il Palermo) e aspettava di imbarcarsi sul traghetto per Napoli. Non c’era andato nessuno per salutarlo. C’ero solo io, che gli avevo chiesto un’ultima intervista, anche se il mio caporedattore al giornale (L’Ora) aveva cercato di dissuadermi: “Lascia perdere, non vuole parlare con nessun giornalista: dice che qui a Palermo non ce n’è uno in grado di capirlo!”. E giù una risatina, che sapeva più di compatimento che di scherno.
Nella confusione tipica di una banchina d’imbarco (auto e persone che aspettano di entrare nella nave) notai subito, pur da lontano, la sua fluente chioma bianca, il suo impeccabile doppio petto, insomma, vidi Viciani e il suo stile inconfondibile, anche nel look: lui era sempre elegante e stilé, cravatta e colletto candido: inverno o estate che fosse, in panchina o in giro per i viali di Mondello che lui, toscano verace – pur nato a Bengasi, in Libia – adorava. Mi avvicinai e un po’ d’emozione l’avvertivo, ma non era la solita emozione, ma qualcosa di più e di diverso: ero anche dispiaciuto, sinceramente dispiaciuto, che un personaggio del suo calibro fosse lasciato andar via così, non dico senza rimpianti ma perfino senza un saluto. Insomma, la prima cosa che mi colpì quel tardo pomeriggio fu la sua solitudine. “Lo chiamano Il Profeta – mi venne da pensare – e chi è più solo di un profeta?” Lui stranamente mi venne incontro, come si fa con un vecchio amico. E mi sorrise: il che era davvero sorprendente, dato il carattere dell’uomo. Mi sorrise, mi strinse calorosamente la mano: insomma, parve contento di vedermi. Come se mi aspettasse. Mi disse: “Eccomi qui, sono pronto!”. Insomma, non aspettava altro che la possibilità di sfogarsi. E farlo con una persona fidata. Gli chiesi come mai proprio con me e lui testualmente spiegò: “Perché lei, anche nella critica, ha rispetto del lavoro altrui, cosa che non hanno i suoi colleghi”.
Subito dopo la retrocessione in serie B nel campionato ’72-73, per un pronto ritorno in serie A, Renzo Barbera aveva pensato a lui. A lui, che aveva portato la Ternana in serie A, ed era la prima volta nella storia della squadra umbra. A lui che, però, in serie A non era riuscito a tenercela che per un solo campionato. Insomma, la mossa di Barbera se non azzardata sembrò sicuramente audace. Ma di quell’audacia che rende se non più bella, sicuramente più avventurosa la vita. Viciani impose subito la sua legge, fatta essenzialmente di lavoro sul campo, e non solo. Fatta anche di tabelle medico-scientifiche, in una parola di scienza applicata al gioco del calcio. Viciani, infatti, fu un precursore. Lo chiamavano già “l’allenatore del gioco corto”, che ai sapientoni del tempo (non mancano mai, in tutte le stagioni e in tutte le latitudini) sembrò subito, come direbbe Fantozzi, una boiata pazzesca. Il “Tiki-taka” tanto in voga in questi anni, a partire dall’imbattibile Barcellona di Pep Guardiola, cos’altro è se non una geniale evoluzione del suo “gioco corto”? Nella sua prima Ternana aveva fatto scintille, visto che con quel tipo di calcio Viciani l’aveva portata in serie A, ma nel Palermo non fu così: due stagioni e due promozioni fallite. D’un soffio, ma fallite. Oltre alla indimenticabile Coppa Italia del 23 maggio del ‘74 “scippata” dal Bologna per via di un rigore-fantasma, visto solo dall’arbitro Gonella.
In definitiva, Viciani fu un magnifico perdente e i perdenti nella vita qualche volta hanno un che di fascinoso, ma non nel calcio, dove contano solo i risultati. Che lui non riuscì ad ottenere. Malgrado la sua “scienza”, le tabelle personalizzate (ogni giocatore, un sistema di allenamento diverso), la preparazione atletica, i supporti energetici, gli schemi di gioco disegnati alla lavagna… Insomma, tutta roba mai vista né sentita a quei tempi nei campi di calcio, roba che, come sempre succede nelle novità, destò più sospetti che entusiasmi. Specie se, alla fine, non si ottengono i risultati sperati. E su questo aspetto, con la sua loquela, che era raffinatissima, lui si dilungò quasi con rabbia: “Sì, è vero, i risultati non sono stati quelli che tutti si aspettavano e me ne assumo la responsabilità, ma vorrei che lo facesse anche qualcun altro!”. E poi, senza bisogno che io lo sollecitassi, aggiunse: “Se i giocatori andavano a lamentarsi in società per la durezza degli allenamenti e ottenevano certi sconti, non venite poi solo da me a chiedere perché si finisce quinti e non primi. Alla Ternana, questo non succedeva e quella Ternana, pur tecnicamente inferiore al Palermo, in serie A ci andò. E di filata!”. Per concludere: “Un allenatore ha le sue idee e deve applicarle. Io ho le mie, so che non collimano quasi per niente con quelle in voga, ma sono le mie idee e se mi lasciano libero di metterle in pratica…”.
Idee dure, difficili, un po’ rivoluzionarie. Da profeta, insomma, E così, dopo la stagione della Coppa Italia mancata d’un soffio e della promozione anch’essa sfumata d’un niente, Viciani pretese la cessione di due “giganti” di quel Palermo: Arcoleo e Girardi. Andarono via anche Cerantola, Magistrelli e La Rosa e arrivarono Trapani, Vianello, Majo, Favalli e Braida: “Preferisco i faticatori ai giocatori d’estro e fantasia”, diceva. E poi precisava: “Attenzione, l’estro e la fantasia mi vanno bene, benissimo, purché al servizio del collettivo e supportati da corsa e sacrificio”. E – lo ricordo bene – come esempio di giocatore d’estro e fantasia e però poco incline alla fatica e al sacrificio fece quello di Vanello. Prima di congedarsi, perché già il traghetto aveva lanciato il suo segnale di fine imbarco, mi disse avvicinandosi al mio orecchio, come un sussurro: “ Io sono quel che sono, prendere o lasciare, ma non tradirò mai me stesso, cioè le mie idee. L’allenatore che lo fa è un poveraccio, anche se vince campionati e si arricchisce”.
Ecco, era fatto così Corrado Viciani, toscano verace di Castiglion Fiorentino, anche se era nato a Bengasi, quando la Libia faceva ancora parte del Regno d’Italia. Era tutto d’un pezzo, un uomo e un allenatore d’altri tempi, ma anche un precursore, uno che aveva nella mente l’idea di un calcio nuovo, quasi rivoluzionario. Mi disse una volta, che era venuto a Palermo con l’Avellino, che lo aveva ingaggiato subito dopo l’esperienza rosa: “Non ho rimpianti per i miei due anni al Palermo, forse qualche rimorso, ma quello col tempo se ne va via. So di aver fatto tutto il possibile, che per un allenatore in pratica vuol dire questo: far sì che i tuoi giocatori nell’arco dei 90 minuti si presentino ameno 4-5 volte davanti al portiere avversario… E questo i miei giocatori lo fanno ad ogni partita”.