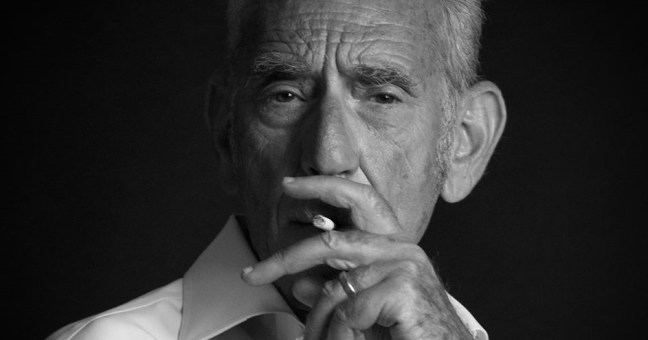Leggo di un incontro organizzato a Palazzo delle Aquile, dalla Commissione Affari generali, in vista del regolamento sul garante comunale dei diritti dei detenuti. Era stata preannunciata la presenza di Totò Cuffaro, cosa che ha suscitato il solito (e, per la verità, un tantino noioso) seguito di polemiche.
Ma non è di questo che intendo parlare. Il fatto è che, ogni volta che si parla del pianeta carcere, io mi comporto come il cane di Pavlov. Ho un immediato riflesso condizionato che mi porta a ripercorrere la mia vita di detenuto.
Proprio così, avete capito bene. Da ragazzo, avevo 16 anni, ho trascorso ben 8 giorni in una cella del carcere minorile di Malaspina per via di una bravata. Avevo tentato di sottrarmi al controllo di due agenti mentre ero in sella al mio “Ciao”. Non avevo alcun motivo per farlo,, ma contavo di poterlo raccontare ai miei amici di quartiere, per vantarmene. Accadde invece che, nel tentativo di fuggire, rotolai sull’asfalto insieme ad un agente che si fratturò un polso, e così mi spedirono dritto dritto in una cella del carcere minorile di Palermo.
Vi sembrerà strano, ma, ogni volta che ripenso a quella esperienza, i ricordi che vengono a galla più facilmente sono legati agli aspetti comici, e anche un tantino surreali della mia detenzione. Pensate, arrivai al carcere intorno a mezzanotte perché dal momento “dell’incidente”, (quasi le 16 del pomeriggio), ero stato trattenuto nei locali di una caserma.
La guardia carceraria alla quale fui consegnato mi disse che purtroppo a quell’ora non c’era più niente da mangiare. Però mi procurò una mela. Io la presi, ma una volta entrato nella cella dove regnava il buio più pesto, mi buttai su un lettino del quale avevo percepito la sagoma. Crollai in un sonno profondo. Non so quanto tempo passò. Mi svegliò qualcosa di umido che mi arrivava in faccia. Una, due , tre volte. Quando aprii gli occhi vidi un tizio. Anzi, la sua ombra. Era seduto su un tavolo, con le gambe penzoloni, proprio di fronte a me. Si stava mangiando la mia mela. La masticava con ritmo. Lo stesso col quale mi sputava le bucce in faccia. Ecco cos’era quell’umido sulle mie guance, sulla fronte, sul naso.
Realizzai subito che non era proprio il caso di protestare. Lo ricordo bene quel volto. Forse è per questo che oggi sono tra coloro che sostengono che le teorie lombrosiane non hanno alcun fondamento scientifico, ma che lui, Lombroso, aveva ragione, ragione da vendere.
Ma non fu quello il momento più brutto del mio battesimo. La prova più difficile dovetti affrontarla quando quello mi chiese “Comu ti chiami?” . Si, perché la prima cosa che pensai fu “come minchia faccio a dirgli che mi chiamo Ennio?”. Non se se mi spiego. Uno che finisce in carcere, in un carcere minorile, non poteva chiamarsi “Ennio”, un nome altisonante, desueto, classico, improponibile, innominabile, inconcepibile in un carcere. Questo è quello che pensavo. “Enrico” risposi con un filo di voce. “Enrico” mi sembrò un alias più che accettabile.
La cosa mi prese la mano. Ecco perché, nel giro di qualche minuto, giusto il tempo di rispondere alle sue incalzanti domande, mi dotai di una nuova identità. Le stesse insondabili ragioni che mi avevano portato a camuffare il nome, forse dettate da un stupido atteggiamento elitario e classista, mi indussero a tacere che ero uno studente del 2°liceo classico e che mio padre era addirittura un professore.
Fatto sta che nel volgere di un baleno ero diventato Enrico, ritiratosi dagli studi dopo la licenza media, e figlio di un pensionato delle ferrovie. Solo il cognome si era salvato. Gli ospiti della struttura venivano chiamati per cognome, come avevo appreso durante le formalità che avevano preceduto il mio ingresso in cella.
Quegli 8 giorni furono davvero una scuola di vita. Imparai un sacco di cose, tipo come si scassa una saracinesca, e come si rompe il finestrino di un’autovettura con la candela di un motore. Ma i compagni di cella (dai curricula di tutto rispetto che spaziavano dal tentato omicidio alla rapina) mi raccomandavano di non farne uso. “Non sei cosa” , mi dicevano, visto che mi ero fatto beccare come un fesso da uno “sbirro” appiedato. Venni scarcerato dopo 8 giorni al termine del’interrogatorio. Proprio così, dopo 8 giorni. Ai tempi non esisteva l’interrogatorio di garanzia.
Cercai di dimenticare tutto in fretta, ma non fu affatto facile. Qualche mese dopo, uno dei miei compagni di cella mi vide mentre ero a Villa Bonanno. Ero con una ragazza. Mi piaceva e l’avevo convinta, con la scusa di doverle dire una cosa importante, a fare una passeggiata in quella villa, meta ideale, ai tempi, per le coppiette. Mi ero pure preparato qualche frase ad effetto. Sul più bello fui fermato da un urlo…..Tinagliaaaaaaa. Mi aveva riconosciuto e mi salutava. Ebbi l’impressione che stesse per avvicinarsi. Afferrai la mano della ragazza e la feci correre con me. “ Che dovevi dirmi”? mi chiese col fiatone. “ Nulla, presto… corriamo… sarà per un’altra volta”. No, non ci fu un’altra volta. Un vero peccato. Non era affatto male.
Chissà perché, ma sono queste le sole cose che ricordo di quella mia esperienza adolescenziale in modalità “Mery per sempre”. Per il resto, dei momenti davvero brutti che pure ho vissuto, solo tasselli. A volte provo a ricomporli, ma sfuggono. Resta solo la radicata consapevolezza che il carcere annienta l’individuo. Come quando prendi la sabbia e provi a trattenerla. Se ne va. Ti restano solo i frammenti. Però la sabbia l’avevi presa. Gli strani effetti, ipnotici e narcotizzanti che produce il decorso del tempo.
Però un ricordo mi è rimasto. Quello si. Intatto. Viene a galla ogni anno, nel mese di maggio. Il volto bellissimo di quel Procuratore della Repubblica che al termine dell’interrogatorio, dispose la mia immediata scarcerazione. Il suo sorriso. Profumava di libertà. Morvillo si chiamava. Francesca Morvillo.